|
 |
|
|
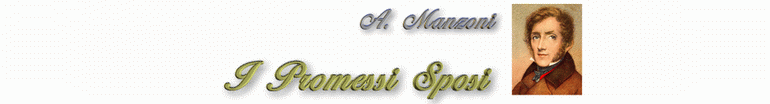
|
|
Cap. 23- 29
|
|
Capitolo 23.
Incontro tra l'Innominato e Federigo e abbraccio di riconciliazione. Il
cardinale, conosciuta la vicenda di Lucia, fa chiamare don Abbondio,
presente con gli altri parroci della zona. e gli dà l'incarico di
provvedere al recupero della ragazza.
Viaggio di don Abbondio, terrorizzato, in compagnia del terribile signore,
fino al castello.
|

Conversione dell'Innominato nella
stanza del Cardinale Borromeo
57
|

Abbraccio tra il Cardinale e
l'Innominato
58
|
|
Liberazione
di Lucia
Clicca sul link di sopra

59
|
Capitolo
XXIV
Il cardinale nella casa del sarto
Lucia è provvisoriamente in paese, nella casa di
un buon sarto, dove subito giunge Agnese e poco dopo il cardinale, cui
Agnese racconta le loro vicende.
L'Innominato, al castello, avverte i suoi uomini che potranno restare al suo
servizio solo se intenzionati come lui a mutar vita.
60
|
Lucia e Agnese si incontrano nella casa
ospitale del sarto

61
|
|
Il cardinale Federigo in casa del sarto
del paese incontra Agnese,Lucia e la famiglia ospitale

62
|
Agnese racconta al Cardinale le vicende
del matrimonio non celebrato

63
|
L'Innominato parla ai bravi:"Dio
misericordioso mi ha chiamato a mutar vita...e anche voi..."

64
|
|
Capitolo
XXV Il
cardinale a casa di don Abbondio
Don Rodrigo pensa bene di lasciare il paese e tornarsene a Milano, prima
d'essere costretto a incontrare il prelato. Il cardinale viene accolto da
don Abbondio al quale chiede informazioni su Renzo.
Lucia viene ospitata da una ricca signora, donna Prassede, col beneplacito
del cardinale, il quale finalmente chiede a don Abbondio perché non abbia
celebrato le nozze dei due giovani.
|

Il cardinal Federigo e Don Abbondio
|

Lucia e Donna Prassede
|
|
Capitolo XXVI
Celebre dialogo tra Federigo e don Abbondio, che sembra ravvedersi, anche se
non nasconde le sue buone ragioni. L'Innominato regala a Lucia una dote di
cento scudi d'oro; ma ad Agnese che porta alla figlia la buona notizia,
Lucia rivela il voto fatto la notte del rapimento.
Decidono così di mandare metà della somma a Renzo e di pregarlo di non
pensar più al matrimonio. Ma non riescono a mettersi in comunicazione con
lui: il giovane ha mutato il proprio nome in quello di Antonio Rivolta e ha
cambiato filanda.
|
Capitolo XXVII
La guerra per la successione del ducato di Mantova, che aveva visto di
giorno in giorno l'Italia settentrionale coinvolta nella guerra europea che
prende il nome di guerra dei trent'anni, impegnava del tutto l'attenzione
del governatore don Gonzalo. Temeva questi che anche Venezia volesse
scendere in campo contro la Spagna: bisognava cercare di distoglierla
facendo la voce forte contro la Repubblica veneta. E l'occasione fu fornita
a don Gonzalo dalla notizia che Renzo si era rifugiato nel territorio
bergamasco. Di qui la finzione delle ricerche condotte per accertare se
Renzo era veramente a Bergamo. Era una formalità: Renzo diventò una
pratica burocratica.
|
Il potere, di lui non s'accorse, perché era sola un
pretesto. Ma Renzo, pur cambiando residenza e nome, continuava a
nascondersi: sapeva per esperienza che del potere politico non ci si poteva
fidare. Una sola cosa lo tormenta: quella di mettersi in contatto con Agnese
e Lucia. Riesce a trovare una fidata trafila e un giorno riceve insieme con
una lettera di Agnese cinquanta scudi: Lucia, era detto nella lettera, non
poteva sposarlo più perché aveva fatto voto di castità. Si mettesse il
cuore in pace e attendesse agli affari suoi. Cosa che Renzo si dichiarò non
disposto a fare. Il suo unico proposito ora sarebbe stato di indurre Lucia
al matrimonio. Lucia, intanto, aveva trovato ospitalità in casa di donna
Prassede, una donna che poco poteva sul marito, don Ferrante, un
intellettuale che da lei si difendeva chiudendosi tra i suoi libri.
|
Così donna Prassede sfogava la sua volontà di strafare e la sua voglia di
fare del bene ad ogni costo (ma il bene coincideva stranamente col suo
concetto piuttosto storto di bene) alle persone come Lucia che si erano
lasciate traviare. Non altrimenti si poteva e doveva spiegare
l'innamoramento della giovane per uno come Renzo che per poco era sfuggito
alla forca e che sicuramente doveva essere un poco di buono, se era
ricercato dalla polizia. Pensiero dominante di donna Prassede era di
liberare la mente di Lucia dall'immagine di Renzo e perciò a lei parlava
spesso e in termini duri ed ingiusti: Lucia per forza di cose doveva
difenderlo da tanta aggressività e così il suo Renzo se lo confermava
sempre più dentro.
|
E sempre più intensamente l'immagine di lui l'assediava, sempre come
risultato dei metodi educativi di donna Prassede. Nulla c'era da temere dal
marito di lei, don Ferrante, un letterato di grande classe: aveva tanti
libri e la sua attenzione si fermava su scienze come l'astrologia e la
duellistica, dove era diventato un'autorità. Era il tipo di letterato
astratto, inutile, formalistica, che non sa legare scienza e realtà,
cultura e società.
|
Capitolo XXVIII
Il narratore si accinge a rievocare i grandi eventi
storici che coinvolgeranno i personaggi del romanzo. Riprendiamo il racconto
della storia milanese dal tumulto si San Martino, egli osserva che le
disposizioni delle autorità che hanno stabilito il prezzo politico del pane
e della farina conducono la popolazione ad un consumo senza risparmio che
aggrava la condizione di scarsità delle scorte. Le leggi cercano di portare
dei correttivi e minacciano gravi pene ai trasgressori finché, intorno alla
data dell’esecuzione dei quattro disgraziati ritenuti responsabili del
tumulto, quella tariffa violenta viene abolita. Ma ormai le condizioni della
carestia sono gravissime e il narratore, sulla scorta delle relazioni del
tempo, intende farne un ritratto. Il lavoro è fermo e Milano è ridotta ad
un indicibile spettacolo. Ai mendicanti di mestiere si aggiungono i nuovi
poveri dei ceti ridotti in miseria: garzoni, operai, servitori licenziati ed
anche bravi. Ma il peggiore spettacolo è offerto dai contadini che dalle
campagne si riversano nella città, nella speranza di un qualche sussidio o
elemosina.
|
|
Le morti diventano sempre più frequenti. Numerosi sono però
anche i segni della carità: sia quella dei singoli, sia quella organizzata
in grande dal cardinal Federigo, che aveva scelto sei preti che girassero
per la città e soccorressero i casi più gravi. Ma il bisogno è così
diffuso che la carità è costretta a scegliere e non basta a portare un
rimedio sufficiente. Il contrasto tra ricchezza e povertà, caratteristico
del secolo, è ora attenuato, perché i nobili mantengono solo
un’apparenza di parca mediocrità. In tali condizioni si profila il
pericolo di contagio. Dopo molte esitazioni viene deciso di concentrare
tutti gli accattoni nel lazzaretto, un edificio costruito precedentemente
per accogliervi gli ammalati di peste. Quelli che vi entrano volontariamente
sono pochi, pertanto si ricorre alla costrizione. Nel lazzaretto le
condizioni di sovraffollamento, di mancanza d’igiene e di promiscuità
rendono ancora più penosa la convivenza e la mortalità aumenta. Il
provvedimento viene così annullato e la città torna a risuonare
dell’antico lamento. Intanto però è pronto il nuovo raccolto: i
contadini tornano al loro lavoro, cessa la carestia e la mortalità
diminuisce. Ma si profila il nuovo flagello della guerra. Gli intrighi
diplomatici tra i grandi, dopo aver posto fine all’assedio di Casale,
portano l’ esercito imperiale a percorrere il Milanese per recarsi
all’assedio di Mantova. Le truppe di Lanzichenecchi, soldati di mestiere
che lo compongono, portano con sé la peste, ma le autorità sottovalutano
questo pericolo. Rimosso per i cattivi successi della guerra, don Ponzalo
lascia Milano accompagnato dagli scherni del popolo che lo incolpa della
fame sofferta sotto il suo governo. Come tutti gli eserciti del tempo, anche
quello tedesco pratica il saccheggio dei paesi che incontra nel proprio
tragitto e la sua discesa attraverso la Valtellina e la Valsassina porta
terrore e distruzione.
|
Capitolo XXIX
Nel paese di Lucia, per sfuggire ai saccheggi, don Abbondio,
Perpetua e Agnese pensano di rifugiarsi nel castello dell'Innominato, dove
confluisce, ben protetta, la gente della zona.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .
|
.
|
.
|
|
|